| |
| |
|
| |
NATO
SCIACCA
Nasce a Patti, provincia di Messina, l’8 gennaio 1907.
Nel 1935 va a Milano per frequentare il corso di scultura all’Accademia
di Brera, e vi si fermerà fino al 1939.
Nel 1940 si trasferisce a Roma, dove continua l’attività
di scultore e partecipa a diverse collettive.
Nel marzo del 1942 sposa Tina Vullo e rientra definitivamente a
Marina di Patti, dove muore il 13 luglio 1995.
.
|
 Manifesto
della mostra.
Manifesto
della mostra.
Messina, Monte di pietà, 2011 |
Dal
catalogo della mostra "Nato Sciacca e l'arte astroabissale"
Consegniamo
oggi alla stampa quanto si è riuscito a raccogliere della
vita e dell’opera di Nato Sciacca, con la consapevolezza di
chi salda parzialmente e dopo troppi anni il tributo che merita
una personalità così alta e importante nel panorama
artistico del nostro Novecento.
Asfissiata da un’inadeguata attenzione, che a tutt’oggi
non ha consentito l’esame critico che la sua opera certamente
merita, la figura artistica di Nato Sciacca è stata distratta
da quella dell’inventore, forse perché ritenuta di
più facile e popolare lettura. Ignorata dagli “addetti
ai lavori”, lasciata nell’ambito angusto della provincia
in cui ha vissuto, abbiamo lasciato scadere la personalità
artistica di Nato Sciacca al livello di “personaggio”.
L’intuizione e la genialità si sono inevitabilmente
corrotte in estrosa o stravagante capacità inventiva.
Eccettuata qualche breve nota critica di Giancarlo Vigorelli, in
occasione di una mostra milanese del 1939, e di un sintetico giudizio
di Giovanni Joppolo (ora ampliato in questo volume da una mia intervista),
nell’archivio di Nato Sciacca non si possiedono, oggi, ulteriori
riflessioni sulla sua opera. Né la poca corrispondenza epistolare
con i più significativi nomi dell’arte e della cultura
del ’900, coi quali condivise gli anni della sua formazione
milanese, aggiungono altro, che non si riferisca alla stima e profonda
amicizia che li legavano a Nato Sciacca.
Abbiamo ritenuto opportuno, per una ricostruzione della figura umana
ed artistica di Sciacca, pubblicare tutti quei brani che nella Doppia
storia, romanzo di Beniamino Joppolo, suo cugino e compagno nella
Milano di “Corrente”, ce lo propongono con lo pseudonimo
di «Masino».
Mancando le indicazioni cronologiche che diano una datazione certa
alle sue opere, e seguendo una ricostruzione biografica affidata
quasi esclusivamente ad una tardiva e lacunosa memoria familiare,
i criteri di chi oggi si trova a “pubblicare” non possono
affidarsi che al sentimento attuale di chi, con stima affetto e
sapienza di altro mestiere, ha un’occasione per dar luce alla
vita e alle opere di Nato Sciacca.
Unico conforto, nell’incertezza di questa rischiosa fatica,
la speranza che si tratti di un primo avvio, di un lavoro iniziale,
utile almeno a documentare, ad un pubblico più attento e
più vasto, il passaggio umano di una personalità di
indiscutibile levatura.
|

Per le
vie di Milano con Beniamino Joppolo (a destra) e un amico

Otan Sciacca



Nato Sciacca
a Venezia
 Nato
Sciacca a Roma Nato
Sciacca a Roma

Fontana
(plastico)

|
MASINO
Abbiamo
stralciato dal romanzo autobiografico La doppia storia di
Beniamino Joppolo, quei passi che raccontano di Nato Sciacca (qui
con lo pseudonimo di Masino) tentando di ricostruire qualche tratto
del suo carattere e qualche episodio che lo ha visto calato nella
familiarità del suo ambiente siciliano o nell’atmosfera
milanese di Corrente (sono individuati altri artisti e intellettuali
che ne fecero parte). Da una superficiale considerazione, la presenza
di Masino-Nato risulta nel romanzo, corposa e ricca, tanto a significare
l’importanza della figura del cugino-amico Nato nella ricca
tormentata e complessa Storia di Joppolo.
Un
cugino della sua età viveva sempre al mare: Masino [Nato
Sciacca], biondo alto forte snello. Lui lo seguiva e ammirava, sopratutto
quando lo scopriva nel grande camerone a pianterreno dove dormiva
con tanti fratelli, tra letti e letti. Lì, Masino gli sembrava
una piccola deità in riposo. Certe volte, a tavola, don Pietro
[Giovanni Joppolo, padre di Beniamino] declamava poesie amorose
o eroiche, e tutti i bambini stavano ad ascoltarlo. I più
grandi di loro spesso già facevano discorsi serii, isolandosi.
Giacomo [Beniamino Joppolo] capiva, ma si vedeva trascurato, e di
ciò non che soffrisse, ne provava malinconia.
[…]
Il giorno dopo, lui e Alberto [Diego, fratello di Beniamino], col
cugino Masino, andarono a vedere la mattanza dei tonni. Sul mare
c’era un grande sole abbagliante. Le barche a vapore giravano
nere e rumorose. I pescatori gridavano, i tonni venivano spinti
e ammassati al centro. A un tratto, da tutte le parti, furono lanciate
contro le schiene nere le picche punture che si conficcavano nelle
carni. I tonni si rivoltavano con guizzi e mostravano i ventri bianchi
da grosse anguille, mentre il sangue arrossava le acque. Il cerchio
delle barche stringeva sempre più i tonni dagli occhi disperati
e dai musi imploranti, sottili come pugnali sconfitti. All’improvviso
le barche irruppero tra i tonni, e i pescatori, con grosse mazze,
urlando come invasati, a colpi poderosi, incominciarono a fracassarne
le teste. Il mare era un grumo di sangue mosso a ondate pesanti,
tra quei corpi lacerati, finalmente inerti.
[…]
Durante l’estate, la famiglia si trattenne al mare sul la
solita spiaggia. Un giorno Giacomo e il cugino Masino, con un grande
sole sul mare, si avventurarono in una lunga gita in barca. Remavano
lentamente, in costume da bagno, e sempre più avevano l’impressione
che i remi, loro e la barca si muovessero in un elemento che non
era né solido né liquido né aeriforme perché
non apparteneva a questo pianeta. A capo scoperto affrontavano sole
e aria con la sensazione che le loro persone venissero sottoposte
a una trasformazione che li rendeva adatti a quel nuovo elemento
dove avrebbero dovuto rimanere per l’eternità, come
sospesi in mezzo a un universo i cui soli componenti erano liberi
spazii e liberi tempi fusi assieme in una sostanza unica, priva
di sostanza e della qualità di sostanza. Solo le loro mani
e le loro braccia seguivano una meccanica di movimenti che era come
una eco che si andava sempre più spegnendo in spazii abbandonati
che appena ricordavano. Gli occhi guardavano attorno la spiaggia
e la terra come un ricordo assurdo di consistenze che non c’erano
più. In questo stato di trasognamento approdarono alla villa
di un amico dove rimasero qualche ora. Poi tornarono indietro.
Masino faceva lo scultore, formava figure in creta, forti ampie
segrete come sassi e che si avviano a diventare esseri vivi o come
esseri vivi che si avviano a diventare granito e minerale. Altri
cugini e altre cugine, altri amici e altre amiche, che erano belli
agili sorridenti, avevano indossato irriconoscibili abiti di carne
diversa e non sorridevano più: negli occhi vuoti sembrava
si meravigliassero che il tempo, invisibile, si divertisse a cambiar
loro, sugli scheletri, i vestiti di carne, di ossa, di nervi, di
sangue e di vene.
[…]
A Milano c’era anche Masino, che faceva lo scultore. Aveva
ricevuto un lascito dalla nonna, col quale pensava di resistere
per qualche tempo facendo l’artista. Lavorava nello studio
di qualche scultore celebre e si affinava rapidamente. Era alto,
bello, tutto ovale, con gli occhi celesti spigliati, biondo, la
barbetta piena di vitalità. Giacomo lo vedeva spesso e trovava
in lui un appoggio morale, e sapeva in più che, in caso estremo,
sarebbe stato anche un appoggio materiale.
[…]
Spesso Giacomo e Masino andavano a mangiare in un’Opera Pia,
un grande edificio antico costruito in mattoni rossi e situato ai
margini di un canale secco, ormai tutto in cemento armato, del Vecchio
Naviglio, antica opera di deviazione fluviale realizzata da Leonardo
da Vinci. Prendevano dei tagliandi a prezzi molto bassi alla cassa
e poi si portavano a tavola, dalla cucina, le pietanze corrispondenti,
abbondanti fumanti forte odoranti in vapori spessi e densi. C’era
una massa di vestiti, di occhi e di volti stralunati, alcolizzati
esattamente come alcolizza l’alcool. Le risate sembravano
autonome dalla catastrofe delle bocche e dei denti precipitanti
da cui provenivano. Masino mangiava con allegria, girandosi su di
un dito e mettendo in evidenza un anello d’oro con sopra una
corona baronale, se ce l’aveva, o altrimenti lo girava immaginariamente
e ne parlava, descrivendolo, lucente dignitoso pesante oro massiccio,
ma assente perché temporaneamente al Monte di Pietà.
Un giorno, un bruno crespo violento gli rivolse la parola, era un
siciliano venditore ambulante di ogni merce, per chiedergli se egli
non fosse il figlio del Cavaliere Tal dei Tali. Masino gli disse
di si. Allora il crespo incominciò a farsi la croce sulla
faccia bruna dagli occhi lucenti scandalizzati, e ripeteva:
– E cosa fa qui e cosa fa qui e cosa fa qui e cosa fa qui.
– Mangio.
– No dico cosa fa a Milano a Milano a Milano.
– Lo scultore.
– Lo scultore? Il marmo? Il legno? La terra? La creta? Il
ferro? Il bronzo? L’acciaio? Un mestiere così vile
e così pesante, un Cavaliere come lei? O Dio, Dio, Gesummaria,
Gesummaria! E viene a mangiare all’Opera Pia? O povero padre
suo! Se lo vede crepa, casca a terra fulminato dal dolore, per carità,
per carità! Se ne ritorni a casa. – E si faceva la
croce fissando Masino come un fenomeno sempre più inconcepibile.
Giacomo e Masino furono insieme presi da una risata convulsa, il
crespo si immobilizzò come una statua di bronzo divenuta
scema e inamovibile, e Giacomo scostava i piatti da Masino, perché
gli era venuta paura che egli potesse prendere i resti delle pietanze
e scagliarle sulla faccia del crespo: gli occhi infatti gli diventavano
sempre più piccoli piccoli piccoli come cimici, e con le
mani frugava l’aria bassa, esattamente come quella volta quando
aveva preso le arancine e le aveva spappolate una dietro l’altra
sulla faccia di luna di quel poveruomo padrone del caffè,
su cui sugo e riso e carne scolavano mentre la bocca diceva agli
occhi smarriti, con un dito disperato e impersuaso che picchiettava
il petto: – A me questo? e perché? perché a
me questo, che vi ho fatte le arancine? –. E tutti guardavano
il crespo e i due, perplessi, ma infine vesti, stracci, gengive
e denti franati nelle bocche terremotate proruppero in un baccanale
di gesti e di risate che, mischiati all’afa degli odori, muovevano
l’aria come una schiuma ubriacata, entro cui gli occhi a masse
si coagulavano come lumache fuori del guscio.
[…]
Certi giorni Giacomo andava anche nella camera d’uno scultore,
Otan [pseudonimo col quale si faceva chiamare, anche ufficialmente,
Nato, anagrammando il suo nome], alto bello sottile e olivastro,
e portava con sé del pane. Otan aveva una cassa di nocciole,
che sembrava non dovesse mai finire. I due mangiavano molto pane
con bocconcini di nocciola, cinque bocconcini per ogni nocciola
in media, e intanto dissertavano a lungo sull’estremo potere
nutritizio delle nocciole, che in una quantità minima contenevano
quantità enormi di sapori piacevoli, di vitamine, di calorie
e persino di sottili elementi erotici. Aggiungevano che chimicamente
pane e nocciole fuse, davano una energia unica, e quindi bastava
mangiarne molto poco, ed era anzi pericoloso abusarne. Sottolineavano
anche che le nocciole contengono l’olio più fine che
esista per bontà e per potere energetico. Dichiaravano che
quest’olio viene usato per gli areoplani e per le macchine
più delicate e più precise. E mettevano in evidenza
anche che con la scorza delle nocciole si fa la polvere da sparo,
sicché bisognava dedurne che anche nella polpa ci dovesse
essere come nella scorza una certa forza da polvere da sparo, pirite
esattamente. E avanzavano l’ipotesi che in fondo, con pazienza,
avrebbero potuto ridurre a polpa la scorza e mangiarla, nel caso
che se ne fosse presentata la necessità. E in tal modo non
riuscivano a buttar via le scorze, ma le conservavano religiosamente
in un’altra cassetta messa allato alla cassa delle nocciole,
dicendo:
– Non si sa mai, per i giorni neri.
E non ridevano, veramente, non ridevano sul serio. Poi uscivano
e passeggiavano a lungo per le strade, fermandosi a bere all’impiedi
qualche bicchiere di vino in un bar, quando avevano i soldi per
poterlo fare. Ma tutto ciò non toglieva che facessero tra
di loro delle festicciole, con ragazze, danze e complicazioni amorose.
Tutti loro, chi più chi meno, coscientemente o incoscientemente,
in modo largo o ristretto, complottavano, e strisciavano dunque.
Questo complottare e strisciare li rendeva fatalmente viscidi ambigui
e viziosi, guardinghi e sfuggenti, anche se sul tronco d’una
natura fondamentalmente sana e forte. Questa miscela di qualità,
piena di reticenze, creava attorno a loro un certo fascino, soprattutto
in ambienti fascisti e in ambienti alti dal punto di vista sociale
ed economico. Diffondevano nell’aria un segreto che attraeva
irritava e incuriosiva. Avevano preso l’abitudine di sorridere
stranamente, senza parlare e rifiutandosi di aprire una qualunque
discussione, guardandosi tra di loro in una carica di sottintesi
che loro soli potevano capire, tutte le volte che incontravano qualche
fascista. Questi finiva per trovarsi irretito nel disagio e nei
dubbi. Lo trattavano con dolcezza estrema, come si può trattare
un bambino infermo, debole di mente e di membra. E il tipo finiva,
così, meccanicamente, col diventare per lo meno un fascista
scontento quando non diventava addirittura un antifascista acceso
e pieno del bisogno di rivalsa contro chi lo aveva sinora ingannato.
Con i più resistenti facevano risultare che per pensarla
in un certo modo, che non dicevano quale chiaramente ma che era
esattamente quello fascista, era fatale dovere essere, proprio dal
punto di vista clinico, un cretino. Figli e figlie di fascisti,
di ambienti fascisti, venivano presi dalla frenesia di essere da
loro redenti e si allontanavano in tal modo dalle loro famiglie,
nei confronti delle quali finivano col diventare molto spesso dei
nemici dichiarati e ufficiali. Sicché molti di essi avevano
amiche belle, ben nutrite, colte, raffinate e svincolate e libere
da ogni punto di vista, padrone assolute di loro stesse. Queste
amavano riunirsi con loro, negli studi, nelle soffitte, nei seminterrati,
ed anzi facevano di tutto per essere degne di loro. E vi trascinavano
anche consanguinei del loro rango.
Il meticoloso intanto sfogliava Retour de l’URSS [di Gide]
con l’aria di uno che capisce una lingua straniera, e contemporaneamente
diceva, con ironica signorilità:
– Bene, bene, vedremo, intanto, per incominciare, lei legge
libri stranieri.
Poi disse: – Ci segua – e fece un cenno agli altri che
erano rimasti di guardia. Questi lo circondarono toccandolo. Egli
provò ancora quel senso di contatto repugnante che aveva
provato con Talella, Tanuzzi e Anteani, e pensava: «No, questa
volta non supero la prova, è insostenibile, questa volta
crepo, non ce la faccio, non potrò resistere». Ma improvvisamente
entrò nello studio Masino, brandendo trionfante uno sgabello,
che aveva il giorno prima promesso di portare a Giacomo. Vedendo
tutta quella confusione capì subito e rimase con lo sgabello
in aria come una statua che fermava bloccato uno sbotto di riso
che stava per nascerle dal di dentro. I questurini lo afferrarono,
lo perquisirono, mentre egli protestava:
– Ma cosa volete da me? Io non c’entro. Io lo scultore
faccio.
Il meticoloso disse:
– Seguiteci.
Giacomo e Masino furono ammanettati e portati fuori, dove c’erano
due grandi taxi con sopra altri questurini. Uno fu messo su un taxi;
l’altro sull’altro. L’alba era già sorta.
Il sole era tepido e giallo, la città dormiva ancora pigra.
I taxi andavano l’uno dietro l’altro. Giacomo pensava:
«Dove andiamo?».
[…]
Ad un tratto gli si presentò davanti il carcere di San Vittore.
Alcuni raggi di fabbricati separati da vuoti ampi e nel mezzo la
cupola d’una chiesa. Fu immediatamente certo di quello che
stava per avvenirgli. Un grande portone si aprì, il taxi
entrò, il portone si richiuse, il taxi si fermò, e
Giacomo fu consegnato a dei carcerieri in divisa grigia. I questurini
scomparvero. Giacomo fu portato in una stanza, dove gli tolsero
cravatta, laccioli e oggetti di ogni specie dalle tasche, e fu invitato
a seguire un carceriere. Il solito mazzo di chiavi enorme come un
organo dai suoni di campana. […]
Il solito corridoio. Le solite porte incastrate nel muro, i soliti
giri di chiave […], e Giacomo, ancora, si sentì richiudere
dietro “le porte della galera”.
Incominciarono a chiamare per nome i carcerati, a cui davano il
caffè del mattino. Giacomo tese l’udito.. C’erano
tutti: Alisio [Aligi Sassu], Peppe [Giuseppe Migneco], Talenti [Italo
Valenti], Tirolli [Renato Birolli], Lananzi [Lattanzi?]... Si trattava
del raggio politico.
[…]
Proprio quella notte Masino era tornato a Milano e disponeva di
una serie di abbaini in un grande palazzo di quel corso. Giacomo
portò da lui la valigia e vi rimase a dormire per un paio
di notti Venivano e andavano ragazze ridenti, sciolte, eleganti,
colte e divertenti. Molte riunioni Giacomo fece con molti amici.
E poi ripartì per la Sicilia. Masino gli disse di ritornare
a Milano, lo avrebbe ospitato, ma con la promessa che non si sarebbe
più occupato di politica. Giacomo rise e gli disse, salutandolo
dal finestrino del treno, che ci avrebbe pensato su. Masino seguì,
correndo, il treno, per salutarlo ancora.
[…]
A Milano [Joppolo] si mise ad abitare da Masino e passò dei
mesi, scrivendo e distendendosi. Vedeva Peppe, Tirolli, Talenti,
che ormai erano artisti ufficiali, arrivati. Faceva qualche lavoro
per le gallerie d’arte e scriveva presentazioni a scultori
e pittori. […] Intanto Giacomo, con Lagrata [Raffaele De Grada],
continuava a svolgere il lavoro di stesura e di diffusione di manifesti,
opuscoli e volantini. Lo faceva con una certa trepidazione, ma ormai
anche con una certa meccanicità. E nascondeva tutto a Masino,
che lo sospettava ridendo e che ora, oltre la scultura, faceva anche
delle invenzioni. Nel piano degli abbaini, di cui diversi erano
stati presi in affitto da Masino che vi abitava con altri artisti
tra cui Giacomo e Talenti, abitavano anche degli artigiani e degli
impiegati: un sarto con famiglia, un parrucchiere con moglie, un
massaggiatore con la sposa, una massaggiatrice, e altri. In realtà
quei locali non potevano essere abitati da artisti. Sicché
i coinquilini facevano una lotta serrata a Masino e compagni, tranne
la massaggiatrice che era troppo bionda delicata e sentimentale
per avere la forza di fare ciò, e allora sorrideva come fosse
permanentemente innamorata di tutto e di tutti. L’ultima trovata
era stata quella di disturbarli mentre essi andavano al gabinetto.
Si riunivano a frotte, gridavano,sferravano calci sulla porta, da
sfondarla:
Principi
e baron
tutti purcon.
Talenti
non soffriva di ciò, perché vi andava solo a lavorare.
Ma Giacomo e Masino, che ci vivevano, in un primo tempo si divertivano,
ma poi, a poco a poco, furono tutti pervasi dalla intimidazione,
sicché un bel giorno stabilirono di risolvere diversamente
la questione: invece di andare al gabinetto accumulavano il loro
materiale viscerale e renale in grandi scatole vuote di latta da
conserva di pomodoro, che Masino usava per la creta, poi le mettevano
in un grande baule che chiudevano ermeticamente. In quel periodo
sia Masino che Giacomo ingaggiavano ragazze da ogni parte e avevano
un complicato traffico di buoni che compravano per mangiare sicuramente
ma che rivendevano quando avevano bisogno di danaro, come per Nanette
e Betty che erano apparse sugli orizzonti del loro cerchio erotico
come fate protese. Masino faceva delle belle sculture, avanzava,
e nello stesso tempo creava un affilatoio, usando il quale una lametta
per barba poteva durare per diverse generazioni. Giacomo aveva,
con Tirolli e Talenti, fondato “la società dell’alcool”,
secondo la quale era inutile fare dell’arte, perché
l’organismo umano l’aveva assimilata rendendola ovvia
meccanica e quindi sangue automatico, che era inutile esprimere
direttamente essendo in tutti direttamente posseduto, mentre invece
inedite e rivelatorie rimanevano ancora le emozioni che poteva offrire
l’alcool trasportando l’organismo verso Dio in regioni
ancora inesplorate. Essi predicavano questi concetti dappertutto
seminando disagio e sgomento, tanto ne erano convinti (o dittatura!).
Ed erano sempre sovreccitati ed ebbri. […]
Una sera Masino riunì nello studio amici ed amiche, per una
festa con musiche e danze, vini e liquori, bibite e acqua. Le ragazze
erano eleganti, felici di conoscere gli artisti nella intimità
dei loro studi, disinvolte ed allegre. Ad un tratto, una di esse,
aveva i guanti bianchi come latte lunghi sulle braccia in tutta
la persona bruna e sfavillante, con una delle sue manine sollevò
il coperchio del baule e disse: – E gli artisti, i cari artisti
cosa tengono di prezioso in questo baule? –, ma subito abbandonò
il coperchio che ricadde rumoroso, e retrocedette stravolta. Un’ondata
calda e profonda di fetore ultramondano da viscere di cadavere invase
l’atmosfera. Dopo il primo sbalordimento stralunato di tutti,
sopravvenne subito uno sbotto di sovreccitazione clamorosa, divertita,
implacabile, come le persone di tutti, lì dentro, fossero
state e continuassero ad essere punzecchiate da cantaridi, da zanzare
cariche di tutti gli stupefacenti più sconosciuti elaborati
da tempo e velocità in un vortice folle e inevitabile. Ma,
dopo la festa, Masino, Giacomo e Talenti sentirono che dovevano
liberarsi del contenuto di quel baule, e chiesero l’aiuto
di Peppe. I quattro stabilirono che nelle due ore dopo la una di
notte avrebbero versato tutto quel materiale sulla strada, che era
una delle più centrali della città. A quell’ora
silenzio e solitudine sarebbero stati assoluti. Il fascismo aveva
abolito spettacoli di ogni genere e aveva chiuso caffè e
locali dopo la una di notte. Sicché a mezzanotte, Giacomo,
Masino, Peppe e Talenti si trovarono assieme per aspettare il momento
adatto alla operazione liberatoria. […]
E così Talenti, Giacomo, Masino e Peppe ritornarono sulla
strada. Si misero a passeggiare su e giù. Gente passava sempre
più rada. Finché si fece il deserto. Su di una bicicletta
un vigile nero e curvo passò, controllò porte, lasciò
biglietti nei negozi, disparve. Allora Masino e Talenti si misero
di guardia sulla strada mentre Giacomo e Peppe salirono negli studi
a prendere le latte colme, metterle nell’ascensore, portarle
sulla strada e svuotarle. Ora, il fetore aveva il ritmo monotono,
da serpente di acciaio strisciante verticalmente, dell’ascensore
che andava su e giù, giù e su, ossessivo, inesorabile
nel budello centrale della casa. Ad ogni latta svuotata e lasciata
per terra i quattro avevano sguardi più liberi. Infine, terminata
l’operazione, si sentirono del tutto allegri e incominciarono
a passeggiare sul marciapiedi di fronte alla casa, aspettando l’alba.
Di fronte a quello spettacolo di merde e di urine putrefatte letali
in pieno centro della città, gli spazzini, i primi ad arrivare,
incominciarono a bestemmiare, più sorpresi che arrabbiati,
mentre con le grandi scope spingevano spingevano, e trovavano roba
per tutte le traverse vicine.
– Ma chi è stato? – qui? – un gigante era
– che stomaco che viscere – roba da matti – una
botte umana doveva essere – incredibile – spaventoso
– una cloaca – un pozzo nero.
Li prendeva quasi, a poco a poco, un terrore mitico, come sospettando
l’esistenza di un mostro nascosto. Talenti, sfiorandoli, disse:
– C’era uno strano tipo, ieri sera, qui, sembrava una
montagna.
Gli spazzini lo guardarono sgomenti.
[…]
Il maggior tempo lo trascorreva con Masino. Come un serpente, capiva
quando Masino aveva soldi. Masino avrebbe voluto seguire un certo
sistema nello spendere, per cui nascondeva a Giacomo i momenti floridi,
per distribuire nel tempo il danaro. Ma Giacomo, avvelenato, ad
un tratto lo afferrava per la giacca, lo scuoteva, stringeva i denti,
lo fissava con le narici tese e gli gridava:
– Fuori i soldi.
Masino si contorceva:
– No, ti giuro...
– Vigliacco, capitalista, tu mentisci, fuori i soldi –.
Masino si divincolava, rideva, si lamentava:
– Ma come fai a capirlo? Io non capisco. Io non capisco.
– Io non voglio neanche sporcarmi le mani con i tuoi sporchi
soldi di mezzo barone siciliano decaduto, che paga il fio delle
sue colpe feudatarie nei confronti dei contadini, jus primae noctis,
e via di seguito, vergogna vergogna e vergogna delle vergogne, ci
siamo capiti, furti, rapine, eredi eliminati, quei soldi maneggiali
tu, andiamo subito a cambiare l’assegno che hai ricevuto.
– Ma ... ma ... come si può vivere con te? Come fai
a sapere?
Masino cambiava l’assegno. Giacomo ordinava sigarette di lusso,
liquori, pietanze, bevande raffinate, si dondolava, sbadigliava,
girava case, aspettava Tirolli e Talenti per la vita della società,
Masino maneggiava lui materialmente lo sporco danaro, e infine Giacomo
si degnava di prendere materialmente del danaro da Masino lo pregava
di prenderlo e crepava dal ridere dandoglielo, ma si rifiutava decisamente
di entrare nella onorata società, perché faceva sculture
e lavorava all’affilarasoio che doveva far durare una lametta,
per le barbe più involute e più complicate, per generazioni
e generazioni, e Masino questo lo spiegava sempre a tutti in tipi
te le occasioni.
[…]
Così passò l’inverno e si avvicinò la
primavera. Giacomo compilava e distribuiva manifestini e volantini,
considerando ciò come un lavoro che lo giustificava come
presenza sociale. Un giorno Masino gli disse:
– Partiamo per la Sicilia assieme a Tirolli. Andiamo a stare
da me.
– D’accordo.
Masino aveva terminato di costruire il suo affilalamette e lo voleva
portare a Roma per proporne lo sfruttamento ad un suo amico uomo
d’affari. Il giorno della partenza, oltre le valigie, aveva
bellamente sistemato la sua macchina in una cassettina. Scendendo
le scale, la cassettina gli era sfuggita dalle mani e si era messa
a rotolare per gli scalini, aprendosi e facendo precipitare la macchinetta.
Allora lui era stato invasato dalla follia, si era messo a correre
inseguendo la macchinetta e, con gli occhi stravolti, strappandosi
i capelli, gridava:
– La mia macchinetta, il mio affilalamette, la mia invenzione,
sono rovinato, sono rovinato, il mio lavoro, si frantuma, si frantuma,
aiuto, aiuto.
Giacomo e Tirolli crepavano dal ridere e gli correvano dietro. Riuscì
ad afferrare macchinetta e cassettina, si assicurò che tutto
era a posto, le ricompose come prima, si incazzò con Giacomo
e Tirolli perché ridevano e non capivano niente del suo dramma,
poi rise anche lui, presero un taxi e andarono alla stazione, si
comprarono un fiasco di vino e partirono per Roma verso la Sicilia.
A Roma, erano già ubriachi. Andarono dal capostazione e gli
chiesero se alle sei del pomeriggio era disponibile un vagone speciale
di terza classe, diretto in Sicilia, per il principe Amleto di Danimarca.
Il capostazione li guardò in faccia, inizialmente sorpreso,
ma subito dopo divertito e sorridente:
– Un vagone speciale di terza classe per il principe, Amleto
di Danimarca, alle sei del pomeriggio? Ma un treno speciale con
tutti vagoni di terza classe ci sarà pronto, per il Principe
di Danimarca, tutti i giorni, a qualunque ora, basta che passiate
dal mio ufficio. E ci metteremo anche delle panchette per la principessa
Ofelia, se non si è ancora affogata.
E, fatta una piroetta, scomparve con un disco rosso in mano, verso
i binari. I tre si smontarono. E non erano più ubriachi.
Come una doccia fredda. Subito per rimontarsi andarono in una trattoria
e ordinarono, irritati, tre bistecche. Intanto che aspettavano le
bistecche bevvero molto. Si sentirono rimontati e incominciarono,
a voce alta, a parlare male di Mussolini, del re, e del papa. Il
padrone, naso lungo a triangolo acuto, colore olivastro trasudato
e corpo secco curvo, si avvicinò a loro e disse, pacifico
e violento (Lenin):
– Se volete parlare male del duce, io me ne frego accomodatevi
pure. Se vi piace parlare male del re, io me ne frego due volte,
e accomodatevi pure cinquecento volte. Ma se parlate male del papa,
dico il papa, potete andarvene dalla mia trattoria, io la bistecca
non ve la servo.
Altra doccia fredda. Si rismontarono. Di nuovo non erano più
ubriachi. Ancora una volta il destino li sfotteva. Il destino: quel
padrone della trattoria. Mangiarono e bevvero con rabbia, ma non
parlarono, erano inibiti. Caricarono le valigie su di un taxi e
se ne andarono da Bartolo [Manlio], il fratello di Masino, commilitone
di Giacomo sotto le armi. Bartolo li accolse molto lieto e disse
loro che potevano rimanere da lui quanto volevano. Si sentirono
rianimati. Bartolo uscì. Rimasti soli, la ubriacatura li
riprese, rimontò.
Poi fecero un bagno tutti e tre. Era sera. Si guardavano reciprocamente
e ridevano soddisfatti. Infine Tirolli disse:
– Usciamo. Facciamo una passeggiata.
– Si – fece Masino.
[…]
Si trovarono in una grande piazza piena di movimento. Molti autobus
andavano in tutte le direzioni circolari, perché la piazza
era rotonda. Masino fece un salto per salvarsi da un autobus, che
stava per metterlo sotto. L’autobus ripartì. Ma Masino
si mise a corrergli dietro. La fermata successiva era il capo linea.
Giacomo e Tirolli correvano dietro Masino. Quando l’autobus
si fu fermato, Masino incominciò a gridare, mentre i passeggeri
scendevano:
– Da Porta San Paolo ci segue. È saltato sul marciapiedi,
è sceso, ha volato, ci ha corso dietro, ci ha pedinati, tamponati,
abbiamo dovuto strisciare, sgusciare come serpi per salvarci, voleva
ammazzarci, massacrarci, eliminarci dalla faccia della terra.
E Giacomo:
– Eh sì, siamo vivi per miracolo.
E Tirolli:
– Per puro miracolo. Ringraziamo Iddio, mi vengono i sudori
freddi a pensarci.
E Tirolli con un fazzoletto si scavava tutto per asciugare un sudore
freddo inesistente. La gente faceva ampio circolo e ascoltava con
un senso di meraviglia. E Masino incalzava:
– Morti ci voleva. Siamo artisti noi. Forse è pagato
da artisti gelosi, perché grandi artisti siamo noi, capaci
di suscitare gelosie mostruose.
E Giacomo:
– Evidentemente. O, semplicemente, non gli piaccio no i nostri
nasi.
E Tirolli:
– Non può essere diversamente. Uno dei due casi, ma
io penso al primo.
Il ragazzo autista impallidiva sempre di più, tremava, diventava
livido, si sentiva offeso, profondamente, tanto più, strano
strano davvero, che la gente ascoltava con serietà un discorso
assurdo su cui si sarebbe dovuto ridere soltanto (o dittatura o
deformazione puerile degli animi!), e ad un tratto reagì:
– Si vede che non siete romani, che siete provinciali, io
sono un pubblico ufficiale nelle sue funzioni e non vi permetto...
Giacomò si esaltò:
– Ecco, a Roma tutti credono di essere dei duci, la solita
frase, pubblico ufficiale nelle sue funzioni.
Si fece rapido avanti un console della milizia, smilzo con barba
smilza e gambali smilzi, e disse con una energia smilza:
– Bene bene, cosa c’è? Chi parla del duce? –
Smarrimento dei tre di fronte a un pericolo. Ma Giacomo si riprese
subito:
– Questo giovane autista ci dà dei provinciali e parla
di pubblico ufficiale nelle sue funzioni come se fosse il duce.
Il console carezzando la barba come fosse una donnola allungata:
– Il duce, il duce, attenzione, giovanotto, a pronunziare
il nome del duce, così, a vuoto, a sproposito.
E Giacomo, energico:
– Noi rispondiamo che di duce ce n’è uno solo,
e che, dopo il duce, che ha fatto dell’Italia un’unità
perfetta sindacalistica corporativistica e imperialistica, non è
consentito parlare di provincia e di non provincia, poiché
siamo tutti una falange, gli italiani.
E Masino:
– Da Porta San Paolo ci segue, e voleva schiacciarci, maciullarci.
E Tirolli:
– Non si sa poi per quali segrete trame.
Il giovane autista era annichilito, avvilito, annullato, tremava
terreo e non parlava più. Il console si lisciò la
barba e disse soddisfatto:
– Bravi giovanotti.
E, rivolgendosi all’autista:
– E voi non tentate più di fare simili scherzi.
E, smilzo come era affiorato, altrettanto smilzo disparve soddisfatto
e disinvolto. I tre si allontanarono. Tirolli disse:
– Partiamo stanotte per la Sicilia, non ne posso più,
per carità. Non facciamo come quei tali che, dovendo partire
da Milano non so per dove, stettero quindici giorni tra casa loro
e la stazione, girando osterie alberghi e ristoranti prima di partire.
Ceniamo con Bartolo e partiamo subito. Io non ne posso più.
Gli altri due furono d’accordo. Sicché, finito che
ebbero di cenare, partirono per la Sicilia, forniti sempre di un
fiasco di vino. Da Roma a Napoli si assopirono. Di tanto in tanto
si risvegliavano, si guardavano ebeti e meravigliati di trovarsi
lì assieme col rumore strisciante del treno sulle rotaie,
sorseggiavano dal fiasco e si riassopivano.
[…]
«Sveglia, sveglia, qui si dorme troppo».
Tutti lo guardarono appena, ostili, e si ripiegarono nel sonno.
Ma Tirolli e Masino si alzarono, svegli anch’essi, e andarono
nel corridoio a raggiungere Giacomo. Tirolli teneva abbracciato
il fiasco sul petto. Il treno ripartì. I tre bevevano a turno.
Ad un tratto si misero ad andare in su e in giù per i corridoi,
guardando ora fuori dei finestrini ora nell’interno degli
scompartimenti. Fuori sfilavano luci, campagne, strade, paesi, fianchi
calcinosi, montagne lontane e vicine. Dentro c’erano teste
chine e volti disagiati e stanchi.
[…]
Il treno precipitava nella notte, gallerie rumorose, fischi, strisciare,
curve. Ad un tratto un tipo magro e livido che sembrava avesse solo
dormito chiese a Tirolli, piano:
– Artisti, eh?
La sua voce era ammirativa. Per cui Tirolli soddisfatto:
– Si. Pittore.
E l’altro:
– Pittore. Bravo.
– Eh, cosa vuole...
– E lei le dipinge, eh, le rose sfatte, le viole sfatte, le
margherite sfatte, la merda putrefatta, eh, neh?
E si voltò dall’altra parte con un profondo disprezzo
tutto concentrato nelle spalle. I tre si smontarono e ritornarono
nel vagone in cui avevano le valigie. Il treno precipitava. Bevvero
ancora per rimontare. Finalmente il mondo enorme, il sud, il mezzogiorno,
sconfinato, cataclismato, angosciante, inebriante, divinamente sputtanato.
Giacomo, per la prima volta, lo guardò con ebbrezza da ubriaco.
I giardini, il mare, sugli alberi, rossi e gialli, le arance e i
limoni a globi e ad ovuli. La gente pensosa e trasognata. Il sole
si fece a poco a poco caldo. Il mare, a destra, mostrava in fondo
la Sicilia.
[…]
Chi doveva ospitare Tirolli? Un fratello di Masino sposava e tutta
la sua casa era in subbuglio. Ma Masino seppe strisciare e temporeggiare
bene. Il matrimonio si fece, con lo sposino in divisa e la sposina
bianca con i fiori d’arancio e il visino da caramella sorridente
e rosea. Tirolli era ospitato un po’ qua e un po’ là,
interessava tutti, persino don Bernardino, e infine si stabili in
casa di Masino. Il padre di questi, a capotavola, era disteso colto
intelligente. Tirolli sproloquiava contro il fascismo. E il padre
di Masino, che non era stato mai fascista, ma al fascismo era stato
sempre ostile, si faceva serio e gli diceva:
– Il fascismo, caro amico, è come una sigaretta.
– Ma la sigaretta è buona – protestava Tirolli.
– È buona? Ammettiamolo. Anche il sigaro è buono.
Io fumo sigari.
– Lo vedo.
– Eppure il fascismo è come una sigaretta.
– E come?
– La appoggi pure sul portacenere o anche ai margini di un
tavolo, la lasci tranquilla, non si occupi di essa, e vedrà
che si spegne da sé. Il fascismo, in conclusione, è
come una sigaretta che si spegne da sé.
– E può anche bruciare la casa.
– Brucerà la casa, ammettiamolo pure, ma ciò
non toglie che non si spenga da sé.
E tutti brindavano.
Tirolli dormiva con sempre sul comodino una bottiglia di vino ambrato,
fatto da don Giuseppe a termini enologici, e con un piatto di passoloni.
I passoloni sono grosse ulive nere, ammuffite per malattia sull’albero:
il gorgonzola delle ulive. Quel vino ambrato era filtrato ed essenziato
di carruba, sicché era secco e nello stesso tempo dolce e
profumato su estensioni di fiori fantastici oltre che su estensioni
di viti e di uva. La notte Tirolli si svegliava, beveva vino, mangiava
passoloni e diceva trasognato:
– Il nettare degli dei innaffia la m..., provocando essenze
e sapori del tutto inediti e scoperti dal nulla dallo zio biblico
Giuseppe.
Lo zio Giuseppe era felice di questo successo del suo vino e rideva.
La frase di Tirolli circolava per il paese, sicché gli procurava
inviti e simpatia, assieme agli amici, da parte di tutti, come forestiero,
come artista e come uomo di spirito.
In
quattro partirono una mattina per una grande gita a piedi. Attraversarono
l’altipiano ondulato a rughe di terre rosse, di messi ancora
verdi, e salirono su di un monte dove sorgeva una villa dello zio
Gerolamo. La villa era proprio sulla cima del monte. La terra stava
sotto. Attorno ad essa gravitavano sole acqua e aria. Anche le montagne
lontane sembravano arie nebbiose con l’ombra di qualche forma
nel cielo, compresa l’Etna che era piú lontana. Il
mare cullava come nubi le isole Eolie verso l’orizzonte. Di
faccia il Tindari macerioso grigio baluginante e turbato da un tempio
massiccio e rettangolare precipitante a picco sul mare. I quattro
trovarono nella villa un bar riccamente fornito. Chiesero a un contadino
una botticina di circa tre litri e l’ebbero. Versarono i liquori
nella bottícina, ne fecero un cocktail e partirono. Ridiscesero
il monte verso il Tindari. I dorsi dei colli e il mare giravano
come cerchi luminosi incastrati ai cerchi fantastici delle montagne
che avevano un movimento profondo sotterraneo dal di dentro, che
poteva far supporre, in sede di pensiero, velocità inconcepibili,
ma che in sede di percezione mostrava velocità limitate nei
confronti della velocità dei cerchi luminosi dei colli e
del mare. Scesi a valle risalirono il monte del Tindari la cui terra
grigia sabbiosa sembrava la continuazione vegetale, a tappeto, degli
ulivi grigi e sabbiosi. Girarono la città antica, piena di
pietre e di archi millenari che sembrava amalgamassero intervalli
e silenzi storici fermi sospesi nell’aria. Il teatro grecoromano
faceva un arco rotto dal mare e dall’aria precipitanti, e
come delimitatrici aveva le costiere di due montagne sollevate come
ali che, distese, cascano dritte e nette sul collo di un uccello
addormentato. |


|
IL
POETA DELL’ARTE ASTROABISSALE
Messina,
Marzo. Parlare con Nato Sciacca è impresa molto facile, basta
andare in Sicilia e fermarsi a Marina di Patti. Lui è là,
e non c’è caso di sbagliarsi perché è
la figura più tipica e caratteristica del paese. Lo vedi
subito che è un pittore, e non solo per qualche [?] sulle
mani o sugli abiti trasandati, ma per quel suo atteggiamento quasi
estatico che lo fa sostare largamente ad osservare il particolare
tono di un’ombra o il giuoco del sole tra le barche in secca
sulla spiaggia. E se non è sulla spiaggia è in casa,
in una vecchia dìmora patrizia assai logorata dagli anni
e dall’incuria. Incuria anche sua, ma lui non se ne preoccupa,
e sostiene che è tutto superfluo ciò che non è
strettamente essenziale alla vita di ogni giorno. Fa quasi uno strano
effetto incontrarsi e conversare con lui, apparentemente fermo nel
tempo, mentre intorno ci si affanna in una gara di rinnovamento.
Diresti che sogna, e forse sogna davvero, in ogni ora della sua
giornata, seguendo pensieri che poi esprime in piccolo tele dove
non trovi figure ma sottile armonia di linee, come di un firmamento
tutto suo, e delicati accostamenti di colori che non son mai orgiastici
anche quando toccano le tonalità maggiori.
Ciò che davvero ti sorprende è sapere che è
proprietario di un cinema nella vicina Barcellona dove ogni tanto
si reca per dare un’occhiata. A1 cinema? Forse no, perché
ha trovato il modo di sistemare anche lì, accanto alla sala
di proiezioni, uno studio di pittura. Ma il cinema prospera anche
senza di lui, ed è questo, oltre ai terreni, che lo rassicura
per i figli; perché si rifiuta di credere che l’opera
d’arte possa ad un certo momento diventare elemento di commercio
e quindi fonte di guadagno. È una concezione un po’
troppo rigorosa, un po’ troppo fuori della realtà per
essere valida ai nostri giorni, e non soltanto ai nostri. Ma Nato
Sciacca non si preoccupa di alcuna sollecitazione degli amici, sorride
tranquillo come chi la sa lunga più di noi, e se insisti
lo trovi già svagato, distratto, a seguire i suoi pensieri:
oppure attacca a parlare con entusiasmo giovanile
di un argomento tutto diverso dove ti è difficile seguirlo
perché forse non pensavi che potesse esistere.
I suoi cinquant’anni non sembrano trascorsi per lui, e ti
racconta le vicende della sua vita artistica di Milano, e dei suoi
studi all’accademia di Brera, come di un recentissimo passato
e di un sistema di vita che prima o dopo dovrà pur riprendere.
E si tratta degli anni dal ’35 al ’40 quando frequentò
l’accademia, dopo gli studi classici seguiti a Patti. Poi
rimase a Milano nello studio dello scultore Arturo Martini, e fece
parte del gruppo molto vicino a Joppolo, Fontana, Sassu, Migneco,
Birolli.
In quel periodo espose varie volte alla quadriennale d’arte
di Milano, e nel ’39 – era ancora all’accademia
di Brera – Giancarlo Vigorelli s’interessò positivamente
delle sue opere e vide in lui giovanissimo una sicura promessa per
l’arte italiana. Così infatti scrisse di lui Vigorelli:
«Presiede al lavoro di Nato Sciacca già una misura,
un ordine, in un giovanissimo sorprendente quasi al punto di legittimare
una esitazione: cioé che egli voglia chiudere in fretta e
anzitempo. E non è. Invece Sciacca sa favorire il suo lavoro
fuori di ogni polemica, di ogni cifra: infatti, sotto il suo ordine,
fresca ancora è l’inquietudine, la piega di ricerca,
lo stimolo. Appunto – come i giovani oggi più pronti
– desiste da una coltivazione acre d’una citata modernità,
e con fiducia e franchezza svolge invece una naturale “contemporaneità”.
In queste notizie non è dato descrivere le intere risorse
di Sciacca. Vogliamo almeno precisare un suo speciale luogo poetico,
una brusca dolcezza a sorprendere il mondo, a meritarsi con forza
quella dolcezza. La sua indipendenza ha già i segni di un
risultato in proprio e di una assai corredata misura morale e poetica».
Nello stesso anno 1539, in occasione di una nuova mostra collettiva
a Milano, così Raffaele De Grada scrisse sul “Corriere
della Sera”: «In tanto avvilente panorama plastico,
una sola opera è degna di essere notata, ed è la Maschera
in cera di Nato Sciacca che denota una grande delicatezza».
È superfluo riportare altri giudizi della critica qualificata
anche perché dureremmo a lungo: abbiamo scelto di proposito
due brani del ’39, quando Sciacca era ancora giovanissimo
e riusciva più di altri a suscitare interesse.
Abbiamo detto che Nato Sciacca sembra un personaggio fermo nel tempo,
ma ci siamo riferiti alla vita dell’uomo e non già
dell’artista. I1 pensiero dell’artista si è infatti
costantemente proiettato nel futuro, in ciò che sarà,
in ciò che potrà essere, in ciò che forse non
sappiamo ancora come e che cosa sarà.
Fin dal 1950 infatti ha chiamato la sua pittura “arte astro-abissale”,
una definizione decisamente suggestiva che involontariamente ci
trasferisce sul piano magico di una fantascienza allora non pur
definita.
Il movimento spaziale fondato a Milano nel ’54 è successivo
di 4 anni alla corrente di Nato Sciacca che ha dimostrato di interpretare
con buon anticipo quali sarebbero state le sollecitazioni degli
artisti suoi coetanei o di lui più giovani.
Ora Nato Sciacca prosegue, sempre costante, nello sviluppo delle
sue concezioni pittoriche dell’arte astro-abissale che lo
impegna in una ricerca metodica, ìn profondità, estraniandolo
dalla nostra realtà quotidiana, dal momento che vive in una
sfera surrealista da lui stesso creata e dove forse lui solo sa
operare.
Il nostro rammarico semmai – se di vero rammarico possiamo
parlare – va ricercato nel suo volontario isolamento che priva
il movimento artistico contemporaneo di un nome su cui decisamente
puntare e non gli consente dì arricchirsi delle sue esperienze
attraverso l’espressione di un’opera profondamente valida.
Pandemonio
[Ennio Salvo D’Andria]
(“Pandemonio”,
11 marzo 1960).
|

Nato e la moglie Tina Vullo

|
STRANE LINEE
La
parte spettantegli dell’eredità della nonna gli fornisce
i mezzi per recarsi a Milano. Fino a quel momento ha vissuto gli
anni della giovinezza a Patti, figlio di famiglia benestante non
costretto a pensare di trovarsi un lavoro, affrontando qualche viaggio
per raggiungere Roma e soggiornarvi dal fratello Manlio.
Beniamino Joppolo, più anziano, è il compagno preferito
di Fortunato Sciacca ventenne. Con lui discute di arte e di letteratura,
presta attento orecchio ad ogni esile notizia che provenga dalla
Francia, per superare i limiti culturali e materiali dell’arte
ufficializzata dal fascismo. Joppolo, che diverrà militante
clandestino della sinistra, s’interessa già di politica.
Nato, no. Non ne ha mai fatta, né allora né dopo.
Eppure nel 1939 per motivi politici finirà a S. Vittore.
Modella la creta, ricrea animali e cavalli, scolpisce pietre tenere.
Certe superfici morbide e levigate del Donatello e di Canova lo
invogliano a trovare forme dal chiaroscuro plastico suggeritore
del movimento. Il modernismo futurista, ridotto a pura accademia,
non soddisfa le giovani intelligenze che non vogliono essere messe
a tacere attraverso i littorali. «Non eravamo disposti
a diventare anche noi pagliacci di una società come era capitato
agli ultimi futuristi » (R. De Grada).
Parte, dunque, in terza classe, dopo aversi fatto confezionare,
a spese del padre, quanti più vestiti possibile, per premunirsi
dei tempi magri che non tarderanno infatti a manifestarsi presto,
malgrado l’assegno mensile che Manlio gli spediva da Roma.
Nella Doppia storia è lo stesso Joppolo –
che Nato venticinquenne si recava a ritrovare a Milano – che
racconta dell’arrivo dell’assegno a Masino e del concorrere
di tutti gli amici per assicurarsi l’utile di un pasto e di
una serata al caffè, fin che i soldi duravano.
A Milano alloggia in una pensione di Piazza Solferino. La padrona,
la signora Giuditta, la fiorentina alla quale Ravel ha dedicato
il celebre Bolero, si circonda di persone amanti della musica e
del canto. La sua voce baritonale attira l’attenzione del
direttore Pieraccioni che vuole costringerlo a studiare al Conservatorio,
che cerca di fargli accettare con insistenti proposte offrendosi
di esentarlo dal pagamento della retta. Il Nostro preferisce frequentare
le libere scuole di nudo dell’Accademia di Brera, consumare
i
pasti alla cucina economica «ai Bastioni», vivere l’intensa
vita serale con Joppolo ed i suoi amici, vendere qualche disegno
a conoscenti del fratello a Roma e lo spunto di una barzelletta
perché Angelo Migneco abilmente la traduca graficamente per
il “Settebello”.
Gli amici che frequenta sono tutti di grande qualità e di
intenso temperamento, fermenti, diversi e contrastanti, uomini liberi
e civili alla ricerca di un messaggio non retorico né decorativo:
Piovene, Vigorelli, Zavattini, De Grada e Rognoni, Jolli (padre
e figlio), Nando e Manzi, per citarne alcuni il cui nome ritorna
alla memoria, che si interessavano di critica e di letteratura.
Badodi, Treccani, Fontana, Birolli, Sassu, Guttuso, Peppino Migneco,
Manzù, Cassinari, Italo Valenti, quelli che esercitavano
la pittura e la scultura.
Per non vedersi costretto a diventare baritono, cambia pensione
e cade dalla padella nella brace. In quella nuova, dove divide la
stanza con l’inseparabile Joppolo, i padroni s’interessano
alla parapsicologia. Le serate sono occasione di sedute alle quali
i nuovi pigionanti sono costretti a partecipare, per condividere
le emozioni – procurate dalle apparizioni che i medium –
alcuni di fama europea – suscitano, proiettando ombre ed ectoplasmi
su una parete.
Vivono questa strana atmosfera di presenze, Nato disegnando e modellando,
Joppolo correggendo bozze per Francesco Flora e scrivendo stupende
novelle che è costretto a far pubblicare ricorrendo a pseudonimi,
per ovviare a possibili veti della censura fascista. Un bel giorno
si trasferiscono in un ampio cantinato con più vani che diventa
lo «studio» di Nato Sciacca. Qui possono ricevere amici
e tenere riunioni, dove tutti gli argomenti che contano sono discussi:
il messaggio di Picasso, l’arte «degenerata» degli
artisti tedeschi, la poesia di Garcia Lorca, gli echi postumi dell’impressionismo,
le proposte di un gruppo di giovani di Roma tra i quali emergono
i nomi di Cagli e di Mafai.
Il rifiuto di soluzioni espressive convenzionali e la verifica delle
proposte che l’avanguardia suggerisce, il recupero della capacità
critica e la ricerca della verità, non sono soltanto occasione
per confrontarsi sul piano artistico e letterario ma anche su quello
politico. Per qualcuno di loro, l’impegno si concretizza in
azione politica antifascista. Una sera, Sciacca, Joppolo e Sassu,
mentre stanno per uscire dallo studio, ricevono un corriere che
viene dalla Svizzera un pacco di manifestini da distribuirsi agli
operai della Breda. Il pacco, che era stato lì per lì
posto in un angolo, viene immediatamente recuperato da Sassu, richiamato
da Sciacca che gli riferisce quanto il portiere dello stabile gli
dice in stretto dialetto milanese: guardi che si sono visti in giro
strani signori. Sassu sale sui tetti, in cima, oltre l’abbaino
dove vive e dipinge, e nasconde il pacco in una fessura. L’indomani
l’Ovra li arresta tutti e tre e recupera, andando diritto
al posto, il pacco svizzero: sicuramente una spiata. Dopo diciotto
giorni trascorsi a S. Vittore, in interrogatorii e lunghe angosciose
attese, Sciacca riesce a convincere della sua estraneità
ad ogni ideale politico. Più pesante è la sorte di
Sassu che subisce dal Tribunale speciale la condanna ad undici anni
di carcere, meno grave quella di Joppolo che se la cava con sei
mesi di confino, pur essendo recidivo di altri periodi di confinamento
in Lucania.
Uscendo dal carcere Nato Sciacca è incapace di trovare lo
stato d’animo adatto per reinserirsi nell’ambiente.
Egli che nei concorsi di Brera è stato segnalato (Bonardi,
De Grada) come scultore di «un certo temperamento»,
che ha studiato con Martini, non ha maturato la forza che gli permetta
di affrontare la realtà che in Italia si sta creando. Raggiunge
a Gorizia il fratello Arnaldo dipendente di quella Prefettura, quasi
a trovare protezione e significare obbedienza al regime, egli che
si è tenuto sempre fuori della politica. Acquietato l’animo
parte per Roma, dove Manlio lo accoglie con l’affetto di sempre
e l’aiuta ad affittare un abbaino nello stesso stabile.
Sono due anni di sereno lavoro. Dal legno e dalla creta nascono
forme e gruppi statuari di ispirazione biblica o suggeriti dagli
atti di vita quotidiana. Sono opere serene e distese maturate nella
mente di un giovane che vive il tempo del fidanzamento con la donna
che sposerà, costruite ed armoniche a rispecchiare la condizione
vitale che intende realizzare per se stesso e la costituenda famiglia.
Torna a Patti e l’ambiente non tarda a risucchiarlo per interessarlo
a progetti di interesse immediato, distogliendolo all’arte
e alla ideatività.
Joppolo scrittore ha stima di Sciacca scultore: «premessa
di tutto ciò una grande stima di te artista ed uomo».
Ma Nato Sciacca non capisce l’avvertimento; costruisce una
sala cinematografica a Barcellona ma la gestisce con la mente distratta
dall’inseguire sogni di ricchezza che dovrebbero derivargli
da brevetti meccanici che gli maturano improvvisi e lo costringono
a lambiccarsi per concretizzarli e a disperdere le forze e le capacità
per vederli riconosciuti.
Gli affari non rendono ed egli è costretto ad indebitarsi.
«La grana col G. è nata da un pregiudizio: un borghesuccio
barcellonese non potrà mai affrontare uno Sciacca figlio
di una Jannelli...», gli scrive Beniamino, che vuole convincere
Nato: «il tuo lato più importante è quello di
essere artista» e lo incita ricordandogli «e l’arte
in questi casi si vendica crudelmente».
Sarà proprio così. Gli eventi della vita incalzeranno.
La famiglia si farà e si disfarà. I brevetti non rinnovati
scadranno. E, nel fluttuare altalenante della quotidianità,
Nato Sciacca rimane a Marina di Patti, rispondendo a chi glielo
chiede che spera di affidare la cura dei beni rimasti al figlio
per raggiungere in Toscana lo studio di uno scultore.
Ma, egli stesso, ci crede poco e, quasi a discolparsi, mostra la
mano sinistra dicendo: «Vedi queste strane linee. Una chiromante
famosa – aveva letto anche la mano a Churchill ed a Mussolini
– mi disse: ci sono segnate due vite e l’una cancellerà
l’altra».
Michele Spadaro
(“Il punto”, dicembre 1978)
|
|
 |


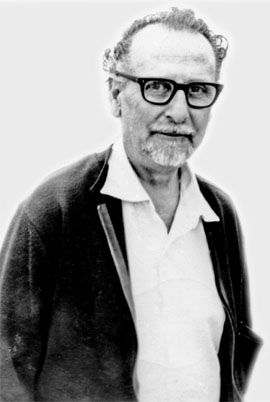





 Nato
Sciacca a Roma
Nato
Sciacca a Roma




